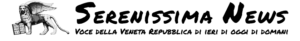Il 1484 fu un anno spartiacque per il Polesine di Rovigo, un territorio fertile, strategico e conteso tra le grandi potenze del Nord Italia. Tutto nacque da una disputa commerciale: il Ducato di Ferrara difendeva le sue saline di Comacchio, mentre la Repubblica di Venezia cercava di affermare il proprio controllo sulla zona per garantirsi autonomia nei traffici sul Po e nel commercio del sale.
La tensione esplose in quella che la storia ricorda come la Guerra del Sale, durata due anni, dal 1482 al 1484. Ma il conflitto andò ben oltre le saline: coinvolse anche il Duca di Milano, il Re di Napoli e Papa Sisto IV, tutti schierati con Ercole I d’Este, signore di Ferrara. Venezia, da sola, fronteggiò la coalizione con fermezza, sia sul campo di battaglia che con la diplomazia. La pace di Bagnolo, firmata il 7 agosto 1484, pose fine alle ostilità e cambiò la storia del Polesine di Rovigo.
Con la pace di Bagnolo il Polesine di Rovigo diventa veneziano
Con la pace di Bagnolo, Venezia ottenne ciò che più desiderava: il controllo definitivo sul cuore del Polesine di Rovigo. Tra le conquiste confermate alla Serenissima ci furono città e territori cruciali come Rovigo, Badia Polesine, Lendinara, Villanova del Ghebbo, le Torri del Doge e le zone limitrofe.
Tuttavia, non tutto il territorio polesano passò sotto il Leone di San Marco. Un altro importante centro del Polesine, Adria, insieme a Corbola, Papozze, Castelguglielmo e la torre di San Donato, venne restituito agli Estensi. Questi luoghi non vennero infatti considerati sotto la giurisdizione diretta del Polesine “marchesco” (veneziano), e rimasero legati a Ferrara, mantenendo così una propria identità e continuità storica.
La pace di Bagnolo segnò quindi una divisione nel Polesine di Rovigo: da una parte, le terre passate a Venezia iniziarono un processo di integrazione amministrativa e agricola; dall’altra, Adria restò simbolo del legame con gli Estensi, confermando l’anima di confine della regione.
Una nuova era per il Polesine dopo la pace di Bagnolo
Il Polesine di Rovigo, sotto Venezia, entrò in una fase di profonda trasformazione. La Serenissima mise in atto una serie di interventi idraulici e organizzativi per valorizzare un territorio che considerava strategico per la difesa e la produzione agricola. Le opere di bonifica, il controllo delle acque e la costruzione di nuovi argini cambiarono il paesaggio e favorirono la crescita di borghi e campagne.
La pace di Bagnolo fu quindi molto più di un semplice trattato: per il Polesine di Rovigo rappresentò un nuovo inizio, fatto di stabilità, investimenti, nuove regole e istituzioni veneziane. Venezia sapeva bene quanto fosse importante tenere saldo il dominio sulla parte occidentale del delta padano, che da lì in poi sarebbe stata chiamata anche Polesine veneziano.
Eppure, proprio accanto, Adria e i suoi territori, tornati sotto Ferrara, continuarono a vivere una storia parallela, divisa solo da confini giuridici, ma unita dalla stessa terra d’acqua e di fiume.
Una pace per tutta l’Italia: il modello Bagnolo
Il trattato firmato a Bagnolo Mella, nel Bresciano, fu un evento storico anche per la sua dimensione nazionale. La pace di Bagnolo non fu soltanto un accordo tra due stati regionali: coinvolse tutte le principali potenze italiane del tempo, che vi aderirono formalmente o informalmente. Milano, Napoli, Firenze, Mantova e persino lo Stato Pontificio trovarono nell’accordo un punto di equilibrio.
La pace prevedeva la restituzione di castelli e bastioni in Lombardia e Veneto, la demolizione di fortificazioni costruite durante la guerra (come Pontelagoscuro, chiamato all’epoca “Lago Oscuro”), e la nomina di Roberto di Sanseverino come comandante generale delle milizie d’Italia. Era l’embrione di una sorta di alleanza panitaliana, fondata più sulla necessità di equilibrio che su una visione unitaria.
Per il Polesine di Rovigo, la conseguenza fu chiara: il territorio entrava definitivamente nel quadro politico veneziano, rafforzando la posizione della Serenissima come potenza continentale oltre che marittima.
Marin Sanudo e le testimonianze della pace di Bagnolo
A raccontarci questi eventi con straordinaria precisione è Marin Sanudo il Vecchio, attento cronista veneziano. Nei suoi Commentarii della guerra di Ferrara, descrive ogni fase delle trattative, compresi gli episodi più curiosi: come quando l’ambasciatore estense Giacomo Trotti, in assenza del Duca malato, si presentò ai veneziani per chiedere perdono e clemenza, promettendo fedeltà futura.
Sanudo riporta anche i dettagli delle concessioni fatte, come il permesso richiesto dal Marchese di riavere la sua casa a Venezia, e la discussione nel Consiglio dei Pregadi sulla ratifica dei capitoli. Le sue cronache ci offrono non solo i dati politici, ma anche il clima e le tensioni emotive che circondarono la pace di Bagnolo.
Grazie a queste fonti, oggi possiamo leggere quella pace non come una semplice fine delle armi, ma come l’inizio di una nuova geografia politica e culturale per il Polesine di Rovigo.
Conclusione
La pace di Bagnolo del 1484 segnò la fine della Guerra del Sale, ma soprattutto aprì una nuova fase storica per il Polesine di Rovigo. Diviso tra Venezia e Ferrara, il territorio visse due destini paralleli: da un lato l’organizzazione veneziana, efficiente e orientata alla produzione agricola; dall’altro, Adria e le sue terre, tornate sotto gli Estensi, continuarono a custodire un’identità più legata alla tradizione ferrarese.
Questa pace dimostra quanto fosse centrale il Polesine nel Quattrocento, non solo per la sua terra, ma per la sua posizione tra i grandi poteri d’Italia. Un territorio di confine che, ancora oggi, conserva nelle sue pietre, nei suoi argini e nei suoi nomi, le tracce di quella svolta del 1484.
📚 Fonti:
-
Marin Sanudo, Commentarii della guerra di Ferrara, 1482–1484
-
Archivio di Stato di Venezia, Senato Secreta
-
G. P. Marchetti, Storia della Guerra di Ferrara, Ed. Rinascita
-
Treccani.it, voce “Pace di Bagnolo”
-
Dizionario Biografico degli Italiani, voce “Ercole I d’Este”
Marco Fornaro