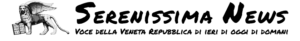L’ultimo libro di Ettore Beggiato, “1797: la Serenissima e l’occupazione napoleonica“, è stato presentato l’11 giugno 2025 in Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, dal Presidente del Consiglio Regionale, Roberto Ciambetti, e da Luciano Sandonà, presidente della Prima commissione consiliare della Regione Veneto, oltre che dall’Autore.
Ciambetti: disegno ideologico di distruzione identitaria
Il presidente Ciambetti (riportiamo più avanti, integralmente, il suo intervento) ha esaminato la figura di Napoleone, “tiranno travestito da liberatore”, notando che il saccheggio napoleonico delle terre della Serenissima non fu soltanto predazione militare, non fu soltanto una serie di rapine, ma fu un disegno ideologico, un consapevole processo di distruzione dell’identità veneta, perseguito abbattendo i simboli della Repubblica e spogliandola di monumenti, opere d’arte e istituzioni nelle quali risiedeva l’identità di un popolo.

Politica, ha annotato Ciambetti, portata avanti anche da chi è succeduto a Napoleone, prova ne siano le censure del saccheggio napoleonico nella narrazione italiana e persino l’invenzione, da parte dei Savoia, “dell’allucinante titolo di Principe di Venezia“.
Sandonà: centralismo italiano eredità di Napoleone
Luciano Sandonà, sulla stessa lunghezza d’onda, ha spinto gli effetti del passaggio di Napoleone fino ai giorni nostri, osservando che “il centralismo italiano di oggi è eredità di Napoleone e dei suoi ordinamenti”.

Ecco qui il VIDEO della presentazione del libro di Beggiato a palazzo Ferro Fini, dal canale Youtube del Consiglio Regionale del Veneto.
L’intervento di Roberto Ciambetti
Ed ecco qui l’intervento di Roberto Ciambetti, che riportiamo integralmente.
Un benvenuto a tutti e un saluto particolare a Ettore Beggiato, figura emblematica dell’impegno democratico dell’autonomismo veneto, che oggi presenta qui a Palazzo Ferro Fini la sua ultima fatica letteraria “1797: la Serenissima e l’occupazione napoleonica” pubblicata dalla Editrice Veneta, prefata da Alvise Fontanella.
La figura di Napoleone Bonaparte, a oltre due secoli dalla sua morte, continua a dividere e ad alimentare un acceso dibattito: fu un tiranno spietato, mosso da un’insaziabile brama di potere, o un liberatore che esportò in Europa i principi della Rivoluzione francese, modernizzando nazioni e abbattendo antichi regimi? La risposta non è univoca.
Napoleone tradì la Rivoluzione
Napoleone Bonaparte fu una figura complessa e poliedrica, un uomo che incarnò le contraddizioni della sua epoca. Fu al contempo un prodotto e un liquidatore della Rivoluzione francese. Ne salvaguardò alcune delle conquiste più importanti, come l’uguaglianza giuridica e l’abolizione dei privilegi, ma ne tradì gli ideali di libertà politica e di autodeterminazione dei popoli. La sua ascesa al potere in Francia avvenne con un colpo di Stato e il suo governo si trasformò progressivamente in un regime autoritario, segnato da clientele e nepotismi.
Nazionalismo aggressivo
Ancora oggi la sua eredità è intrinsecamente ambivalente. Se da un lato ha lasciato un’impronta indelebile sulla modernizzazione delle istituzioni e delle leggi in Europa, dall’altro ha rappresentato un modello di potere autoritario e di nazionalismo aggressivo. Fuori dal Veneto, giudicare Napoleone esclusivamente come un tiranno o un liberatore significa semplificare la realtà storica estremamente complessa di uno dei personaggi più controversi discussi e discutibili della storia del mondo. Fuori dal Veneto, ripeto, perché in Veneto, e già durante l’occupazione francese e persino tra non pochi giacobini, la critica aspra su Napoleone non si fece attendere.
Ugo Foscolo: hai venduto Venezia!
Ugo Foscolo, veneziano di Zante, che era entrato entusiasta nell’esercito napoleonico, vide la sua sincera fede giacobina infranta dal cinismo del Corso che aveva ceduto Venezia ai nemici austriaci, un autentico tradimento dei principi rivoluzionari. Nelle sue “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, Foscolo non esita a denunciare le contraddizioni napoleoniche: “E tu, Francia, tu che promettesti libertà ai popoli, hai venduto Venezia”. Insomma, Napoleone, e non solo per Foscolo, fu un tiranno travestito da liberatore, un moderno Machiavelli, che baratta ideali con vantaggi geopolitici.
In una sua ode inedita, ma conosciuta attraverso citazioni, Foscolo definisce Napoleone “Nuovo Attila”, “Aquila di Rapina”, “Empio distruttore dell’arte e della libertà”, definizione questa sulla quale è necessario, oggi più che mai, riflettere.
“Cancello la Repubblica di Venezia dalla storia”
Venezia e la sua Repubblica cedute all’Austria con il Trattato di Campoformio del 1797, sono l’esempio emblematico di come gli ideali rivoluzionari fossero subordinati alla spregiudicata realpolitik napoleonica. Nel suo proclama agli italiani del 16 maggio 1797 Napoleone scrisse, tra le altre cose, una frase su cui bisogna riflettere: “La Repubblica di Venezia è giunta al termine della sua esistenza. Il suo nome stesso sarà presto cancellato dalla storia.” aggiungendo poi “Popoli dell’Italia, siate liberi. La caduta di Venezia è il trionfo della giustizia e della ragione contro il privilegio, l’oppressione e la tirannia.”
Sei mesi dopo, con il trattato di Campoformio, Napoleone cedeva i territori dello stato veneto all’Austria, alla faccia della libertà, mentre il processo di distruzione della memoria era già stato avviato attraverso un’opera di spoliazione incredibile, un sistematico saccheggio di opere d’arte, tesori religiosi e patrimonio culturale in tutte le terre della Serenissima. Oltre alla perdita materiale, quel gesto segnò l’inizio di una ferita simbolica ancora aperta nella memoria collettiva del Veneto.
Progetto ideologico di distruzione identitaria
Il saccheggio napoleonico non fu un atto casuale di predazione militare. Al contrario, rispose a un progetto ideologico preciso che nel caso della Serenissima assunse i contorni di una distruzione identitaria: non solo vennero prelevati quadri e sculture, ma anche smontati altari, trafugati codici miniati, fusi oggetti sacri, rubati documenti e mappe, depredate le Scuole cittadine, saccheggiato l’Arsenale e distrutto il Bucintoro, simbolo stesso della sovranità veneziana.
Lo stesso saccheggio si replicò nei territori e nelle città veneziane. In altre parole, un atto di conquista totale, materiale e spirituale. Il colpo inferto alla città e alla Repubblica fu duplice: la perdita fisica di tesori e la rimozione della centralità culturale di Venezia. Venezia non fu più un centro autonomo, un motore creativo, ma un corpo minore annesso, prima alla Francia e poi all’Impero asburgico e quindi al Regno dei Savoia, che s’inventarono persino l’allucinante titolo dinastico di Principe di Venezia per l’erede al trono.
La resistenza di Antonio Canova
L’arte, che per secoli aveva celebrato la magnificenza della Serenissima, con Napoleone fu decontestualizzata, smembrata e dispersa, il che non è solo una questione estetica o patrimoniale, ma una lacerazione nella continuità della memoria urbana e spirituale. Antonio Canova, l’artista veneto che, dopo il Congresso di Vienna, si fece promotore delle restituzioni delle opere trafugate, rappresenta la prima forma di resistenza morale e culturale a quella ferita.

Canova comprese che riportare le opere nei loro luoghi d’origine era un modo per ricomporre un’identità collettiva violata. La sua missione diplomatica fu coronata da un successo molto parziale: alcune opere ritornarono, ma molte furono definitivamente perdute, anche perché alle potenze europee poco interessava la faccenda. Ciò nonostante, Canova fu un costruttore di memoria e giustizia culturale. La sua azione ci ricorda che la cultura non è neutra, ma profondamente intrecciata al potere, alla dignità dei popoli, alla loro narrazione storica.
La censura italiana del saccheggio napoleonico
Non è un caso se per lungo tempo, la memoria del saccheggio napoleonico fu trascurata nella storiografia ufficiale e praticamente censurata nella coscienza pubblica italiana. In parte perché la figura di Napoleone, come ho detto all’inizio del mio contributo, fu oggetto di una narrazione ambivalente: tiranno per alcuni, modernizzatore per altri. In parte perché l’identità nazionale italiana, costruita nel Risorgimento, tendeva a privilegiare l’unità sulla memoria delle ferite locali.
A Vienna e a Roma fa comodo annichilire l’identità veneta
Anche a Vienna, come a Roma poi, sarebbe tornata utile l’amnesia totale, l’oblio, sull’unico stato che in Europa non fu restaurato dopo il Congresso di Vienna: a troppi faceva comodo annichilire l’identità di uno stato e di un popolo. Per capire la portata di questa operazione e del processo di distruzione dell’identità basti pensare alla Slovenia, che nella storia non era mai stata uno Stato unitario, ma che aveva una propria precisa identità che nel giugno del 1991 trovò espressione nell’indipendenza e nell’affermazione della sovranità di uno stato di circa 2 milioni e duecentomila abitanti.
Ricordare, un atto di consapevolezza
Oggi, ricordare il saccheggio non è un gesto revanscista, ma un atto di consapevolezza: ci ricorda che la cultura, e l’identità, può essere violata, e che le opere d’arte non sono solo oggetti, ma testimoni del tempo e dell’anima di un popolo. La ricerca di Ettore Beggiato va inserita in questo contesto. La memoria del saccheggio napoleonico a Venezia ci interroga su cosa significhi possedere un patrimonio, su come si costruisce l’identità attraverso la bellezza e la storia, come aveva del resto profeticamente avvertito Ugo Foscolo chiamando appunto Napoleone “empio distruttore dell’arte e della Libertà”.
Leopardi: Napoleone grande, ma come rovina
In un’epoca di nuove guerre e nuovi esili culturali, Venezia ci parla ancora, non solo come città del passato ma come monito universale, mentre per l’ombra di Napoleone – non senza dimenticare Alessandro Manzoni che da democristiano ante-litteram affida ai posteri l’ardua sentenza – non possiamo non riflettere sulle parole di Giacomo Leopardi che nella lettera a Pietro Giordani del 27 novembre 1820 scrive “Napoleone m’ha sempre fatto un senso misto d’ammirazione e di riso. E’ un mostro sublime: grande, ma come una rovina. Non ha portato che disastri e illusioni” lasciando, aggiungiamo noi, una ferita profonda e mai rimarginata nell’anima dei veneti, come testimonia questo ultimo saggio di Ettore Beggiato.