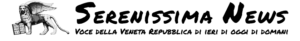Eugenio Piva: patriota e coscienza storica di Rovigo
Eugenio Piva nasce a Rovigo il 1° novembre 1820 da una famiglia profondamente legata al territorio polesano. Fratello del patriota Domenico, fu egli stesso risorgimentale convinto, ma non cieco. Impiegato presso il Genio Civile, si occupò per tutta la vita delle vicende idrauliche dei fiumi del Polesine, ma coltivò anche la passione per la memoria storica, l’arte, l’architettura, lasciando una raccolta manoscritta di eccezionale valore: Rovigo nel secolo XIX. Ricordi di Eugenio Piva, con 35 carte manoscritte e 19 disegni a penna. Donata all’Accademia dei Concordi nel 1892, quest’opera non è solo una cronaca cittadina, ma anche una riflessione intima e sincera su ciò che la città stava diventando dopo l’unificazione italiana. Piva non ha l’asprezza del polemista, ma la lucidità disincantata del testimone. Nonostante avesse creduto nel sogno risorgimentale, seppe denunciare ciò che vide accadere alla sua gente.

10 luglio 1867: la festa che si trasformò in rivolta
È sera a Rovigo. Si dovrebbe celebrare con spettacoli e festeggiamenti l’anniversario dell’arrivo delle truppe italiane in città. Ma qualcosa stona. Il giorno prima, alcuni cittadini sono stati arrestati per diverbi con la banda municipale. La popolazione lo sa, e non ci sta. Si raduna spontaneamente in piazza, chiedendo la liberazione dei fermati. E qui scatta la risposta dello Stato: la piazza è circondata dalle truppe, la folla caricata a baionette inastate. In pochi minuti si passa dalla celebrazione alla repressione. Venti persone vengono arrestate. Rovigo sembra in “piena rivoluzione” scrive Eugenio Piva. Ma chi era davvero il nemico? Non c’erano fucili tra i manifestanti, solo voci e rabbia. Eppure fu trattato come un moto sovversivo. Il popolo, quello vero, capì in quel momento che la nuova Italia non era madre, ma padrona. E quella sera, la “liberazione” svelò finalmente il suo volto armato.
Non erano liberatori: lo Stato sabaudo e il tradimento della fiducia
Quella sera del 1867 a Rovigo fu molto più che un episodio locale. Fu il simbolo di una frattura. Il Regno d’Italia, appena insediatosi in Veneto dopo l’annessione del 1866, si presentava alla popolazione con il volto della burocrazia e della forza militare. La speranza di un’Italia nuova, giusta, aperta, si infranse presto nella realtà di un regime centralista, fiscale, opprimente. I cittadini si trovarono a fare i conti con tasse quadruplicate, nuovi regolamenti, una burocrazia paralizzante e un numero mai visto prima di carabinieri e agenti. La presenza dello Stato era ovunque – tranne che nel cuore del popolo. Eugenio Piva, da tecnico e cronista, annota questi mutamenti con amarezza, e la stampa non resta indifferente. Il disincanto serpeggiava ovunque, e anche coloro che avevano salutato con entusiasmo l’unità iniziarono a pentirsi. La promessa era libertà. La realtà era controllo.
La voce de “L’Arena”: “Tre volte tanto di carabinieri”
Una delle testimonianze più clamorose arriva proprio da Verona. Il 9 gennaio 1868 – appena quindici mesi dopo l’arrivo dell’Italia – il quotidiano L’Arena scrive:
“Fra le mille ragioni per cui noi aborrivamo l’austriaco regime, ci infastidiva sommamente la complicazione e il profluvio delle leggi e dei regolamenti, l’eccessivo numero di impiegati, e specialmente di guardie e di gendarmi, di poliziotti, di spie.
Chi di noi avrebbe mai atteso che il governo italiano avesse tre volte tanto di regolamenti, tre volte tanto di personale di pubblica sicurezza, carabinieri, ecc.”
Non sono parole di nostalgici né di reazionari, ma di cittadini che avevano creduto nel sogno risorgimentale. Lo Stato italiano si era rivelato più presente, più esigente, più opprimente di quello austriaco. Quelle parole, oggi dimenticate, sono uno schiaffo alla retorica celebrativa, e danno voce a un sentimento popolare che i libri scolastici hanno rimosso: non tutti accolsero il tricolore con entusiasmo.
Conclusione – Un popolo dimenticato, un’Italia imposta con la forza
Il 10 luglio 1867 non è solo una data. È una ferita. È il momento in cui una parte del popolo veneto comprese che la tanto attesa Italia non era quella sognata nei salotti né nelle adunate. Era una realtà dura, fiscale, militare. E quella realtà la raccontò uno di loro, Eugenio Piva, con onestà e dolore. Sei mesi dopo, nel gennaio 1868, il malcontento esplose ovunque: in Polesine, nel Veronese e in tante zone del Nord Italia, il popolo insorse contro la tassa sul macinato, simbolo tangibile di un’Italia che non ascoltava ma imponeva, che non liberava ma riscuoteva. Era un assedio fiscale, e il Veneto ne fu tra le prime vittime. L’unificazione, per molti, non fu una conquista ma una sostituzione di padroni. E in troppe piazze, come a Rovigo, la baionetta prese il posto del dialogo. Non si trattò di libertà, ma di occupazione in uniforme tricolore.
Fonti
-
Eugenio Piva, Rovigo nel secolo XIX – Ricordi di Eugenio Piva, manoscritto donato all’Accademia dei Concordi, 1892
-
Il Corriere del Polesine, 16 novembre 1892 e 19 febbraio 1903
-
L’Arena di Verona, 9 gennaio 1868 – articolo tratto dal libro “Questione Veneta” di Ettore Beggiato
-
Documentazione introduttiva dell’opera manoscritta (foto fornite)
-
Studi sul malcontento post-unitario in Veneto