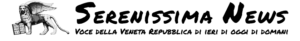Le proposte per il riconoscimento ufficiale delle lingue e culture regionali e delle “minoranze nazionali” assumono certamente il valore di un’azione politica importante per rafforzare l’autonomia e l’identità storica e culturale dei popoli regionali.
Le sentenze della Corte Costituzionale, sullo specifico argomento, hanno tuttavia posto limiti precisi e un freno a questa azione politica, sottolineando il principio di unità e indivisibilità dello Stato, che impedisce di considerare i “popoli regionali” come entità autonome.
Bisognerebbe quindi individuare una strategia alternativa, efficace e innovativa, e considerare strumenti non solo legislativi, ma anche culturali e comunicativi, per rafforzare il senso di appartenenza e identità. La sensazione, tuttavia, è che molto tempo sia stato perduto e che le battaglie epocali, alla fine, si siano dimostrate funzionali più al mantenimento delle posizioni di potere che al raggiungimento di risultati concreti.
ll disegno di legge sulla lingua siciliana
È stato recentemente presentato all’Ars, l’Assemblea Regionale Siciliana, un disegno di legge, promosso dai Deputati del gruppo Popolari e Autonomisti, con il supporto di movimenti come Trinacria e Cademia Siciliana, che mira a riconoscere ufficialmente la lingua siciliana come parte dell’identità culturale della regione, inserendola tra le minoranze tutelate dalla legge n. 482/1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

La tutela delle minoranze linguistiche in Italia
Nell’art. 6 della Costituzione italiana, il termine “minoranze” è utilizzato unicamente in relazione a quelle “linguistiche”, impegnando la Repubblica ad assicurare loro una particolare tutela tramite “apposite norme”. La legge n. 482/1999 tutela specificamente le “minoranze” linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.
Il disegno di legge presentato all’Ars rappresenta quindi un tentativo di valorizzazione culturale inserito in un più ampio contesto di tutela e riconoscimento dell’identità del popolo siciliano, anche se gli sviluppi della proposta rimangono incerti e prevedibilmente soggetti a contrasti ed opposizioni.
In questo senso, si ricorda la sentenza n. 81 della Corte Costituzionale del 2018, che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale veneta n. 28/2016, la quale aveva superato il concetto di “minoranza linguistica” qualificando il “popolo veneto” come “minoranza nazionale”, riconoscendo, in applicazione degli artt. 1 e 2 dello Statuto Regionale, i diritti di cui alla “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali” del Consiglio d’Europa ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 364 (art. 1).
LEGGI ANCHE Contro l’Autonomia, dalla Consulta una sentenza politica che riscrive la Costituzione
La Corte, in particolare, ha affermato che il “popolo veneto”, così come definito nello statuto regionale, è da considerarsi l’intera comunità della regione, senza attribuire uno status di minoranza etnico-linguistica, e ha sottolineato che il riconoscimento delle minoranze si applica a gruppi con caratteristiche culturali, linguistiche o etniche specifiche, e non all’intera popolazione regionale. Pertanto, anche se nello statuto regionale si enuncia che “Il Veneto è costituito dal popolo veneto“, questa definizione deve essere riferita a tutti gli abitanti della regione senza costituire una identità etno-linguistica separata, in conformità ai principi costituzionali di unità e indivisibilità.
La sentenza sull’autonomia differenziata
E’ poi intervenuta la sentenza n. 192/2024 della Corte Costituzionale, che ha scomposto come un cubo di Rubik la legge sull’autonomia differenziata di matrice leghista. Questa decisione non solo ha risposto alle aspettative dell’opposizione, ma, probabilmente, anche a quelle, più velate, di altri partiti di governo che finora non avevano mai mostrato un grande entusiasmo sulla stessa questione.
Tra gli aspetti tecnici complessi della sentenza, emerge un rilievo di impatto dirompente, anche di natura politica, su tutte le richieste attuali e future di autonomia e federalismo: “Esiste una sola nazione, così come vi è solamente un popolo italiano, senza che siano in alcun modo configurabili dei ‘popoli regionali’ che siano titolari di una porzione di sovranità.”
In altre parole, la Corte ha affermato che non può essere accettata alcuna richiesta di autonomia territoriale fondata su criteri etnoculturali o etnofederalisti, che riconoscano un “popolo regionale” come titolare di sovranità. Esiste soltanto la nazione e il popolo italiano. Nella sentenza, il concetto di integrità territoriale dello Stato viene pertanto associato a quello di nazione e di popolo, che vengono considerati come anch’essi unici e indivisibili.
La necessità di trovare soluzioni pratiche
Perché intraprendere iniziative legislative che rischiano di portare a risultati paradossali e controproducenti, come le sentenze che affermano che il popolo veneto non può essere considerato una “minoranza nazionale” e che “i popoli regionali non esistono”‘? Questi esiti, che sembrano negare l’identità e la specificità di un’intera comunità, rappresentano dei veri e propri “autogol” che compromettono inesorabilmente qualsiasi possibilità di una azione politica per l’autodeterminazione e di riconoscimento identitario. E, di fronte a tali risultati clamorosi, perché poi continuare a rimanere in uno stato di attesa infinita, prospettando ancora esiti epocali ed alimentando speranze di sviluppi che ancora non si vedono e che restano troppo indefiniti, invece di affrontare con decisione e chiarezza le questioni fondamentali?
L’approccio del “soft power”, una strategia efficace?
Dal mio punto di vista, sarebbe stato più opportuno adottare una strategia basata sul cosiddetto soft power, piuttosto che incorrere periodicamente in inutili conflitti istituzionali e scontri frontali. Si sarebbe dovuto adottare una strategia di lungo termine, integrando tradizione e innovazione e puntando su azioni concrete e mirate.
In questo particolare contesto, il soft power si configura come la capacità di esercitare un’influenza significativa nel dibattito politico e sull’opinione pubblica attraverso strumenti principalmente “immateriali” di natura culturale, intesa in senso ampio, che suscitino attrazione ed ammirazione. Questa strategia dovrebbe creare un’immagine positiva favorendo la costruzione di un consenso che possa contribuire a tutelare le identità culturali e le “minoranze nazionali” evitando inutili contrasti istituzionali.
Un esempio di promozione di cultura storica nelle scuole veronesi negli anni ’70 e ’80
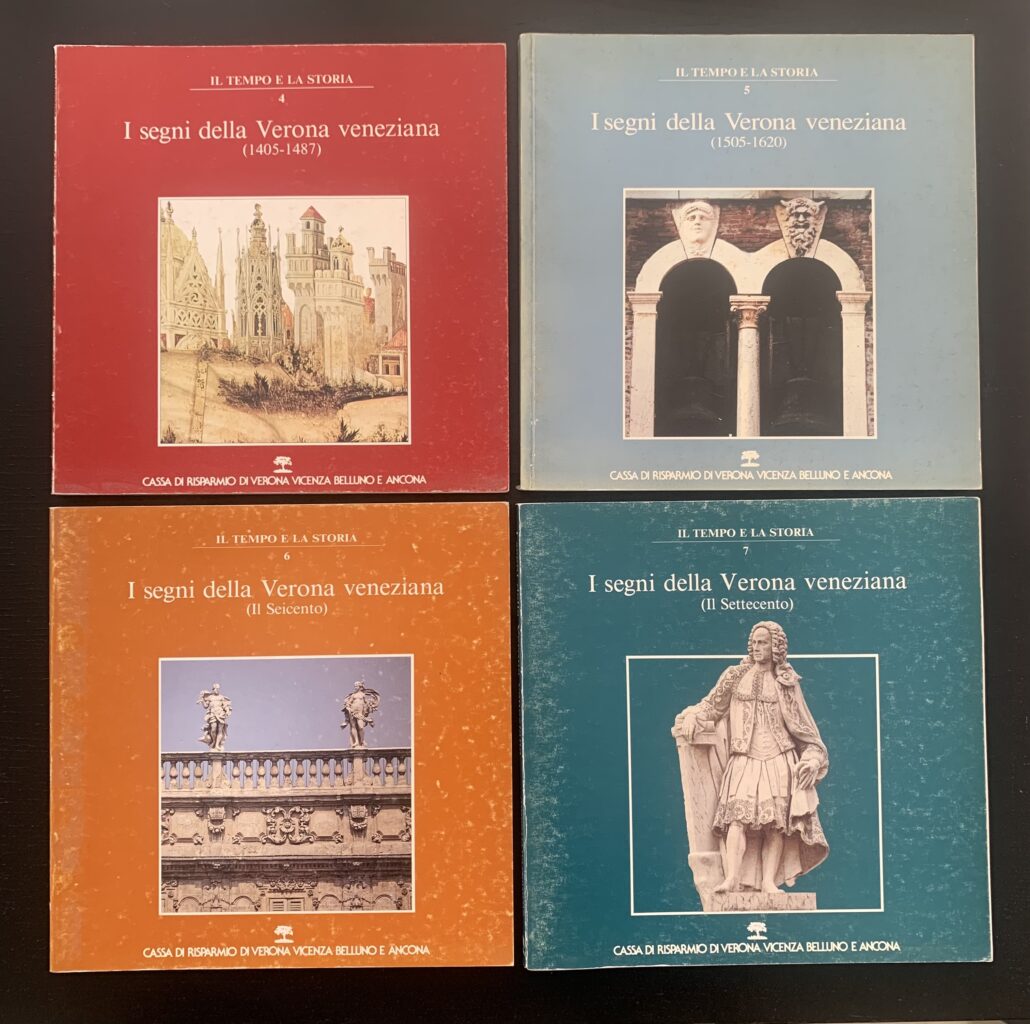
La Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, dal 1977 al 1984, ha pubblicato una serie di opuscoli intitolata “L’ambiente veronese”. Questi volumi, dedicati ad aspetti storici del territorio con titoli come “Verona e gli Scaligeri: 1277/1404”, “Verona con la Serenissima tra il Quattrocento e il Cinquecento” e “Verona con la Serenissima: dal Concilio di Trento alle Pasque veronesi”, venivano distribuiti ai ragazzi delle scuole medie della provincia. Includevano anche quiz dedicati a promuovere la conoscenza storica tra i giovani lettori, integrando di fatto il programma scolastico di storia. L’iniziativa aveva lo scopo di promuovere e far conoscere la storia e il patrimonio culturale del territorio, sviluppando indirettamente anche un senso di appartenenza tra i giovani veronesi. Di analogo interesse anche la successiva serie “Il tempo e la storia” comprendente ben quattro testi dedicati a “I segni della Verona veneziana”.
La modernizzazione delle strategie di divulgazione culturale
Oggi, considerando le possibilità offerte dalla tecnologia informatica, sia le istituzioni pubbliche che i soggetti privati potrebbero riproporre un’azione simile, ma con modalità più moderne e accessibili: distribuendo, ad esempio gratuitamente in formato PDF pubblicazioni sulla storia e la cultura locale o creando un’apposita “biblioteca digitale” liberamente accessibile, con testi di ogni epoca dedicati alla lingua veneta.
Questa strategia potrebbe essere vista come un esempio di “soft power” culturale, volto ad accrescere la conoscenza ed influenzare positivamente il dibattito pubblico, rafforzando il senso di identità locale senza ricorrere a strumenti di imposizione legislativa di natura politica, che portano inevitabilmente a contrasti istituzionali.
Ovviamente, l’elenco delle cose giuste da fare, come scrive Drew Westen in “La mente politica”, può avere più o meno lo stesso impatto emotivo della lista degli indumenti da portare in lavanderia. In questo senso, sotto il profilo emotivo, dovrebbero venire in soccorso le arti come la letteratura e il cinema, declinato anche nelle “serie televisive”, e soprattutto la musica, purché abbiano sempre al centro l’identità storica e culturale.
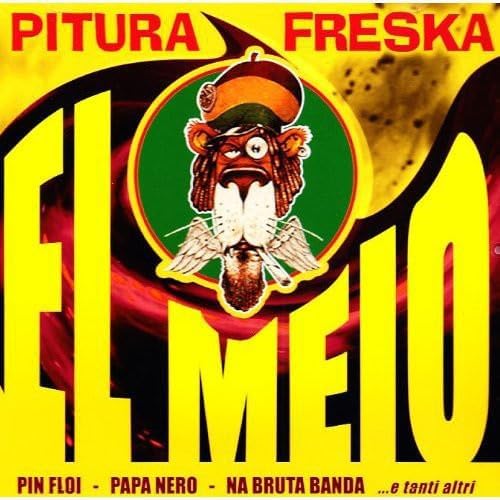
Ricordiamo certamente i Pitura Freska, che si distinsero negli anni ’90, e oggi sarebbe interessante apprezzare finalmente artisti veneti che si esprimano in lingua veneta nei vari generi attuali, andando oltre l’underground e la goliardia.
Il rapper napoletano Geolier, che utilizza la sua lingua nel contesto contemporaneo affrontando anche temi controversi, dovrebbe essere valutato come un interessante esempio di una forte espressione identitaria, che lo ha portato ad affermarsi con successo con una sua canzone presentata a Sanremo della quale, peraltro, in un simpatico siparietto, ha fornito anche una esibizione proprio in lingua veneta.
La saggezza strategica di Sun Tzu per un nuovo venetismo
Come affermava Sun Tzu, “Compi azioni mirate e individua i punti in cui l’avversario è più vulnerabile, il suo pieno e il suo vuoto”, sottolineando l’importanza di riconoscere e sfruttare le debolezze strategiche piuttosto che impegnarsi in conflitti sterili e frontali.
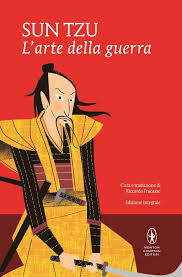
Nel contesto attuale, segnato da un quadro geopolitico elettorale nel Nord e in Veneto, dove le forze politiche meno inclini a sostenere l’autonomia e il federalismo prevalgono, la vera saggezza dovrebbe risiedere nel saper quando e dove intervenire per cambiare le condizioni che ostacolano l’affermazione di un progetto identitario radicato nella cultura e nella storia veneta.
Purtroppo, sembra che molto tempo sia stato perduto e che non sarà facile recuperare gli ultimi trent’anni passati a proclamare grandi progetti, spesso disattesi.
CUOREVERDE